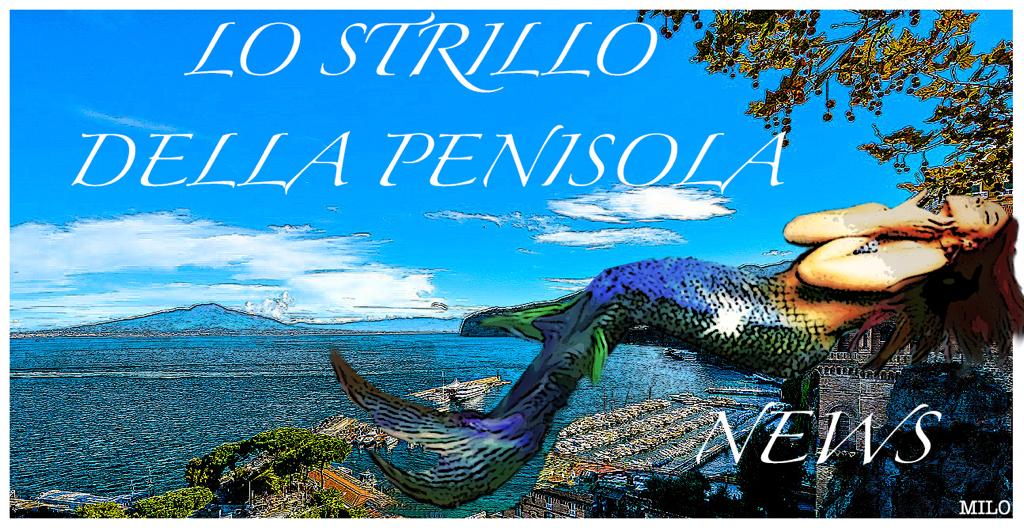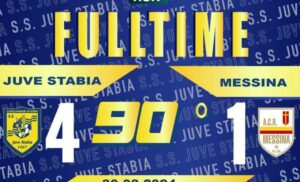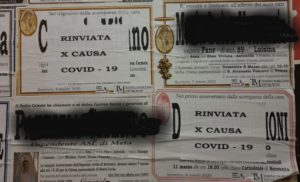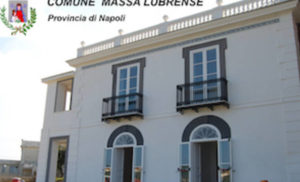IL DIKTAT DEL SILENZIO
“Ci stanno creando solo problemi e minano alla nostra credibilità”… questo il sunto del silenzio della Curia e dell’Ufficio delle Confraternite di Sorrento, in merito alle ormai note vicende che si sono succedute alle elezioni dei Governi della Confraternita dei Giuseppini e dell’Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco e Agnello di Sant’Agnello.
Il problema è che gli uffici preposti, non assumono nessuna posizione, in quanto invece di essere avulsi da ogni logica cospirativa, vengono tirati “per la giacca” da vari esponenti politici e del mondo imprenditoriale, di conseguenza, com’è di solito logico pensare da parte degli esponenti della Chiesa, lasciamo che i toni si abbassano, facciamo passare del tempo così che si sgonfia il caso.
E no, mi dispiace, lo scrivente sarà la vostra spina nel fianco fino a che Dio mi darà forza.
Questo perché avete sempre sottovalutato le Confraternite, il loro ruolo e le loro finalità, dimenticando che le Confraternite sono istituzioni cariche di storia.
Le origini delle Confraternite non sono rintracciabili nel tempo. Certamente possono essere fatte risalire alle prime comunità cristiane. L’associazionismo fu una esigenza che i primi cristiani sentirono per realizzare la fratellanza e la piena comunione di amore con Cristo secondo il principio evangelico: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”(Mt 18,20). La storia delle confraternite è strettamente connessa con la storia della Chiesa.
Le confraternite, come le conosciamo oggi e dalle quali le attuali discendono direttamente senza interruzioni, iniziarono ad esistere nel secolo XII come istituzioni e come associazioni di fedeli erette per l’esercizio di opere di carità, di pietà e di incremento del culto pubblico.
La fiducia che riscuotevano nei fedeli e l’esempio di povertà, di carità e di rettitudine contribuirono enormemente a salvare la Chiesa negli anni della divulgazione delle eresie. I laici, associati in confraternite, permisero alla Chiesa di essere presente in tutti gli ambienti e costituirono un vero tessuto connettivo di fronte alla quale l’eresia non ebbe la possibilità di attecchire.
I membri delle confraternite, del resto, a differenza di quelli delle congregazioni religiose, hanno sempre avuto un vantaggio perché, a prescindere che non emettono voti, vivono e professano la loro fede liberamente nella società e non sono strettamente legate ad una regola.
Le confraternite, quindi, nel corso dei secoli, hanno rivestito costantemente un ruolo importante e si sono mantenute fedeli e presenti negli scopi: la missionarietà, la pietà, il culto e l’esercizio della carità.
Esemplare è stata la loro evoluzione storica, in quanto hanno avuto la capacità di interpretare i segni dei tempi, hanno saputo adattarsi ai cambiamenti delle condizioni della storia e si sono fortemente difese da attacchi e sistemi repressivi.
L’esistenza delle associazioni nella Chiesa – tra le associazioni rientrano anche le confraternite – è una realtà evidente ed è approvata dalla Chiesa. La dottrina canonica antecedente al Codice di Diritto Canonico del 1917 riconosceva implicitamente il diritto dei fedeli di costituire associazioni, di promuovere tra i loro membri una vita cristiana più perfetta, di esercitare opere di pietà e di carità e di incrementare il culto pubblico.
Nel Codice Piobenedettino le associazioni costituivano il contenuto esclusivo del Libro II, parte III, De Laicis, con l’evidente contraddizione di includervi anche le associazioni formate da chierici, o da chierici e laici.
Si comprende come la dottrina canonica successiva al Codice del 1917 abbia messo in evidenza le contraddizioni tra la normativa sulle associazioni e l’effettivo riconoscimento del diritto di associazione nella Chiesa, teoricamente recepito nell’ordinamento canonico.
Il Concilio Vaticano II ha apportato novità e profondo cambiamento, offrendo i presupposti ecclesiologici adeguati ad una nuova comprensione del diritto di associazione.
CONF  L’Assemblea Conciliare, infatti, ha esplicitamente proclamato questo diritto e ne ha precisato il fondamento. Al riguardo, il Decreto Apostolicam actuositatem al n. 18 afferma che: “I fedeli sono chiamati ad esercitare l’apostolato individuale nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l’uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il Popolo di Dio (cfr. 1Petr. 2,5-10) e un unico corpo (cfr. 1Cor. 12,12).
L’Assemblea Conciliare, infatti, ha esplicitamente proclamato questo diritto e ne ha precisato il fondamento. Al riguardo, il Decreto Apostolicam actuositatem al n. 18 afferma che: “I fedeli sono chiamati ad esercitare l’apostolato individuale nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l’uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti in Cristo per farne il Popolo di Dio (cfr. 1Petr. 2,5-10) e un unico corpo (cfr. 1Cor. 12,12).
Il Decreto Presbyterorum ordinis al n. 8 proclama: “Vanno anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che, in base a statuti riconosciuti dall’autorità ecclesiastica competente, fomentano – grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e approvato e all’aiuto fraterno – la santità dei sacerdoti nell’esercizio del loro ministero, e mirano in tal modo al servizio di tutto l’ordine dei presbiteri”.
Il Codice di Diritto Canonico del 1983, in piena coerenza con lo spirito e la lettera del Vaticano II (cfr. AA 18 e 19; PO 8; CD 17), afferma esplicitamente al can. 215 il diritto dei fedeli di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, di incremento pubblico del culto o della vocazione cristiana nel mondo (cfr can. 299, §1; can.327). Tale diritto ha la sua fonte nella stessa natura sociale dell’uomo, che trova la sua pienezza nel battesimo.
Come diritto del fedele di associarsi, quindi, scaturisce dal battesimo e non da una concessione dell’autorità, e corrisponde pienamente alla natura stessa della Chiesa come comunione tra tutti coloro che credono in Cristo.
Per questo l’esercizio di tale diritto non può che avvenire nella comunione ecclesiale, con il riconoscimento e la tutela dell’autorità ecclesiastica, in modo che i fedeli associati si inseriscono nella missione della Chiesa. È sotto questa luce che va letta tutta la legislazione, o meglio, lo spirito della legislazione sulle associazioni di fedeli che troviamo nel Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 298-329).
L’Esortazione Apostolica post-sinodale Christifideles laici di S. Giovanni Paolo II del 30 dicembre 1988, al n. 30, rilascia i criteri fondamentali per il discernimento delle aggregazioni di fedeli laici nella Chiesa. Tali criteri valgono per ogni tipo di associazioni e vi rientrano anche le confraternite.
Sulla base dell’insegnamento pontificio tali criteri si possono riassumere e coincidono con le finalità:
-
Favorire e promuovere una vita più perfetta. Le associazioni debbono essere strumenti di santità per i loro membri. Ciò viene verificato dalla loro fedeltà verso il Signore e dalla docilità allo Spirito Santo, quindi dall’uso di mezzi di santificazione concordi con la dottrina, la disciplina e la tradizione della Chiesa. Del resto il primo fine, che il can. 298, §1 elenca, è di ordine prettamente spirituale, religioso e ascetico: favorire e promuovere una vita più perfetta (ad perfectionem vitam fovendam).
Una vita perfetta…? Strumenti di santità per i loro membri…?
Macché, la Curia e l’Ufficio delle Confraternite di Sorrento, hanno dimenticato tutto quanto innanzi scritto, loro utilizzano le Confraternite come quando a casa viene a trovarci un ospite e si tira fuori l’argenteria più buona, per fare bella figura.
Che importa se alcuni membri delle Confraternite non hanno rispetto dei canoni religiosi? Ormai i tempi sono cambiati e noi siamo Clerici del rinnovamento.
Di quale rinnovamento? Voi abiurate tutto ciò che è scritto e sancito dal Codice e da tutte le encicliche ordinate. E quindi visti i mancati provvedimenti, mi chiedo: “ma un po’, non vi vergognate?”
Il Confratello
Rosario Salerno